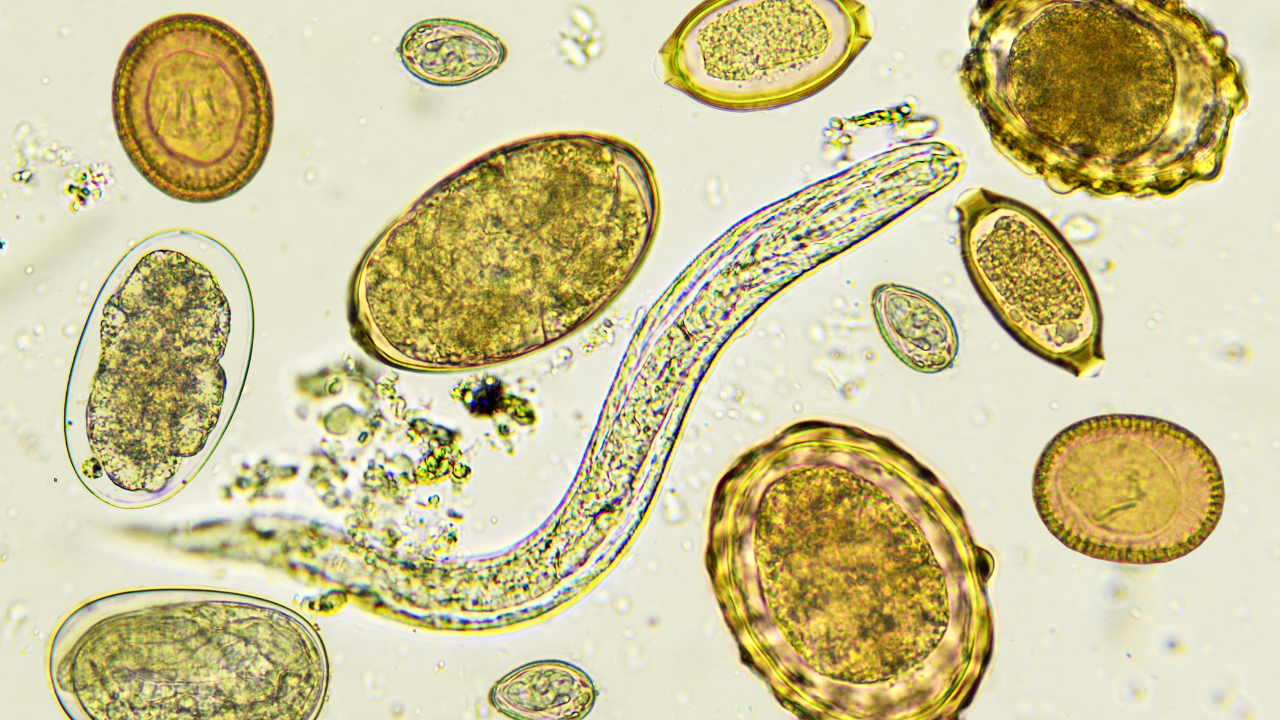Stitichezza: come riconoscerla, cura e quando preoccuparsi

La stipsi è una delle problematiche gastroenterologiche più diffuse nella popolazione generale, con una prevalenza che oscilla tra il 2% e il 27% nei paesi occidentali, e un significativo impatto sulla qualità di vita dei soggetti affetti. Questa condizione, spesso banalizzata o gestita impropriamente attraverso l'automedicazione, si configura come un disturbo complesso multifattoriale, che può manifestarsi come entità funzionale primaria o come sintomo secondario a numerose condizioni patologiche sottostanti.
Stitichezza, il significato clinico
La stitichezza, tecnicamente definita come stipsi, rappresenta una condizione caratterizzata da evacuazioni intestinali infrequenti, difficoltose o incomplete. Dal punto di vista clinico, viene generalmente diagnosticata quando si verificano meno di tre evacuazioni settimanali, accompagnate da feci dure, secche o di piccolo volume, e da uno sforzo defecatorio eccessivo.
I criteri diagnostici definiscono la stipsi funzionale sulla base della presenza, per almeno tre mesi, di due o più dei seguenti sintomi: sforzo evacuativo in più del 25% delle defecazioni, feci dure o grumose, sensazione di evacuazione incompleta, sensazione di ostruzione/blocco anorettale, necessità di manovre manuali per facilitare l'evacuazione e meno di tre evacuazioni spontanee settimanali.
La fisiopatologia della stitichezza è complessa e multifattoriale, potendo originare da alterazioni della motilità intestinale, disfunzioni del pavimento pelvico, anomalie della sensibilità rettale o combinazioni di questi fattori.
La stitichezza cronica, invece, si configura quando la sintomatologia persiste per almeno tre mesi consecutivi nell'arco di sei mesi. Questa forma rappresenta un'entità clinica distinta, con implicazioni significative sulla qualità di vita e potenziali complicanze a lungo termine. La stipsi cronica può essere classificata in primaria (funzionale) o secondaria a condizioni organiche, farmacologiche o sistemiche.
La forma primaria comprende la stipsi con transito normale, la stipsi con transito rallentato e la disfunzione del pavimento pelvico. Le forme secondarie possono derivare da patologie neurologiche (morbo di Parkinson, sclerosi multipla), endocrinologiche (ipotiroidismo, diabete mellito), metaboliche (ipercalcemia), psichiatriche, o dall'uso cronico di farmaci (oppioidi, antidepressivi, anticolinergici, calcio-antagonisti).
Le cause della stitichezza
Le cause della stitichezza sono complesse e multifattoriali, comprendendo cause funzionali, organiche, farmacologiche e correlate a specifiche condizioni fisiologiche o patologiche.
Stitichezza in gravidanza
La stipsi in gravidanza è un disturbo estremamente comune, con una prevalenza stimata tra il 38% e il 50% delle gestanti. I meccanismi fisiopatologici alla base di questa condizione comprendono fattori ormonali, meccanici e funzionali: l'aumento dei livelli di progesterone determina un rilassamento della muscolatura liscia intestinale con conseguente riduzione della motilità e rallentamento del transito. Questo effetto è particolarmente evidente nel secondo e terzo trimestre, quando i livelli ormonali raggiungono il picco. Parallelamente, l'aumento volumetrico dell'utero esercita una pressione meccanica sul sigma e sul retto, contribuendo alla difficoltà evacuativa.
Anche le modificazioni della dieta e dell'attività fisica che spesso si verificano durante la gestazione possono influire negativamente sulla funzionalità intestinale.
Menopausa e stitichezza
Il periodo perimenopausale e post-menopausale si associa frequentemente a disturbi della funzionalità intestinale, con una prevalenza di stipsi che può raggiungere il 25-30% delle donne in questa fase. La riduzione dei livelli estrogenici gioca un ruolo fondamentale nella patogenesi, influenzando negativamente la motilità colica e la sensibilità rettale. Gli estrogeni, infatti, esercitano normalmente un effetto procinético sul tratto gastrointestinale attraverso l'interazione con specifici recettori presenti sulla muscolatura liscia intestinale.
La deplezione estrogenica si associa inoltre a modificazioni della composizione del microbiota intestinale, con riduzione dei batteri produttori di acidi grassi a catena corta, importanti regolatori della motilità e della secrezione intestinale. Le alterazioni del tono dell'umore e i disturbi del sonno, frequenti in menopausa, possono contribuire ulteriormente alla stipsi attraverso meccanismi neuroendocrini.
Celiachia e stitichezza
Contrariamente alla presentazione classica caratterizzata da diarrea, la malattia celiaca può manifestarsi con stipsi in un numero significativo ma contenuto di persone, configurando la cosiddetta "variante stiptica" della celiachia.
Questa presentazione atipica è più frequente nella popolazione pediatrica e negli adulti con forme subcliniche o paucisintomatiche. I meccanismi patogenetici sottostanti non sono completamente chiariti, ma comprendono alterazioni della motilità intestinale secondarie all'infiammazione cronica della mucosa, disfunzioni dell'asse intestino-cervello e possibili neuropatie enteriche correlate all'autoimmunità.
Stitichezza da stress
La correlazione tra fattori psicologici e alterazioni della funzionalità intestinale è ben documentata nel contesto dell'asse intestino-cervello. Lo stress, sia acuto che cronico, può indurre o esacerbare la stipsi attraverso complessi meccanismi neurobiologici che coinvolgono il sistema nervoso autonomo e l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. L'attivazione dell'asse dello stress comporta il rilascio di catecolamine e cortisolo, che influenzano direttamente la motilità intestinale, determinando tipicamente un rallentamento del transito colonico.
Alcuni sintomi correlati alla stitichezza da non sottovalutare
La stipsi si manifesta con un quadro sintomatologico variabile, caratterizzato primariamente da:
evacuazioni infrequenti (meno di tre defecazioni settimanali);
feci dure o grumose;
sensazione di evacuazione incompleta;
necessità di eccessivo sforzo durante la defecazione;
dolore addominale di intensità variabile.
Questa costellazione sintomatologica può associarsi a manifestazioni extraintestinali significative, alcune delle quali meritano particolare attenzione clinica. La relazione tra stipsi e mal di schiena rappresenta un'associazione clinica frequentemente sottovalutata. Il dolore lombare nei pazienti con stipsi cronica può manifestarsi attraverso diversi meccanismi fisiopatologici:
accumulo fecale nel colon discendente e sigma determina una distensione intestinale che può irradiare alla regione lombare attraverso vie nervose viscero-somatiche condivise;
lo sforzo defecatorio eccessivo e ripetuto può causare microtraumi della muscolatura paravertebrale, contribuendo alla sintomatologia algica;
l'alterata postura che alcuni pazienti assumono per compensare il disagio addominale può indurre tensione muscolare e squilibri biomeccanici con conseguente lombalgia.
La presenza di sangue nelle feci in un paziente con stipsi rappresenta un sintomo d'allarme che necessita pronta valutazione diagnostica. L'ematochezia in questo contesto può originare da diverse cause:
le feci dure e voluminose possono determinare microlesioni della mucosa rettale o anale, manifestandosi tipicamente come strie ematiche sulla superficie fecale o carta igienica;
le emorroidi interne o esterne, frequenti nei pazienti con stipsi cronica a causa dell'aumentata pressione venosa durante lo sforzo defecatorio, possono sanguinare durante il passaggio di feci dure;
ragadi anali, causate dal traumatismo ripetuto durante l'evacuazione di feci di consistenza aumentata, che si presentano tipicamente con dolore anale acuto durante e dopo la defecazione associato a tracce ematiche.
È fondamentale sottolineare che il sanguinamento rettale, specialmente se ricorrente, scuro o associato a modificazioni recenti dell'alvo, deve sempre essere considerato come campanello d’allarme.
Stitichezza e diverticoli
La correlazione tra stipsi cronica e malattia diverticolare rappresenta un'associazione clinica complessa e bidirezionale.
I diverticoli colici, estroflessioni sacciformi della mucosa attraverso la tonaca muscolare del colon, presentano una prevalenza crescente con l'età, interessando fino al 50-70% della popolazione occidentale oltre i 70 anni.
La relazione tra diverticolosi e stipsi è ulteriormente complicata dal fatto che, una volta sviluppati, i diverticoli stessi possono esacerbare la stitichezza attraverso meccanismi di alterata motilità segmentaria, ipersensibilità viscerale e modificazioni del microbiota intestinale.
La gestione terapeutica del paziente con diverticolosi e stipsi richiede un approccio integrato che comprenda l'incremento dell'apporto di fibre solubili, idratazione adeguata e regolare attività fisica, con l'obiettivo di normalizzare il transito intestinale e ridurre le pressioni intraluminali, prevenendo sia la progressione della malattia diverticolare che le complicanze infiammatorie.
La visita gastroenterologica nel trattamento della stipsi: approccio diagnostico-terapeutico
La visita gastroenterologica è il momento diagnostico fondamentale nell'iter valutativo del paziente con stipsi, particolarmente nelle forme croniche, refrattarie o associate a sintomi d'allarme.
Il gastroenterologo, attraverso un'anamnesi strutturata e sistematica, indaga dettagliatamente le caratteristiche temporali della sintomatologia, la frequenza evacuativa, le caratteristiche delle feci secondo la scala di Bristol, la presenza di dolore e/o meteorismo, l'eventuale associazione con altri sintomi gastrointestinali ed extraintestinali, nonché la risposta a precedenti trattamenti.
L'esame obiettivo comprende la valutazione dell'addome, con particolare attenzione alla presenza di masse palpabili, meteorismo o dolorabilità alla palpazione, e l'esplorazione rettale digitale, che fornisce informazioni preziose sulla presenza di fecalomi, tono sfinterico, alterazioni anatomiche e patologie del canale anale.
Sulla base dei dati clinico-anamnestici, lo specialista può prescrivere indagini di primo livello (esami ematochimici, ecografia addominale) o approfondimenti diagnostici specifici come il tempo di transito intestinale, la manometria anorettale, la defecografia o la colonscopia, indispensabile nei pazienti con sintomi d'allarme o età superiore ai 50 anni.
Il valore aggiunto della consulenza specialistica gastroenterologica risiede nella capacità di inquadrare la stipsi nel contesto clinico globale del paziente, distinguendo le forme funzionali da quelle secondarie e impostando strategie terapeutiche basate sull'evidenza scientifica e modulate in funzione della fisiopatologia sottostante, con l'obiettivo di migliorare non solo la sintomatologia intestinale ma anche la qualità di vita complessiva.
Rimedi
I rimedi contro la stitichezza comprendono un approccio sistematico e graduale, che tenga conto della fisiopatologia sottostante, della severità dei sintomi e delle caratteristiche individuali del paziente. Le strategie terapeutiche comprendono interventi non farmacologici, terapie farmacologiche e, nei casi refrattari, opzioni procedurali o chirurgiche, ciascuna con indicazioni, meccanismi d'azione ed efficacia specifici.
Rimedi naturali contro la stitichezza
Le modificazioni dello stile di vita rappresentano il primo livello di intervento nella gestione della stipsi:
aumento dell’apporto idrico, con un'assunzione giornaliera di almeno 1,5-2 litri di liquidi, favorisce l'idratazione del contenuto intestinale, facilitando il transito e l'evacuazione;
incremento nel consumo di fibre alimentari, fino a 25-30 g/die, contribuisce all'aumento della massa fecale e stimola la peristalsi intestinale. Le fibre solubili (psillio, glucomannano) sono generalmente meglio tollerate rispetto a quelle insolubili (crusca), che possono esacerbare meteorismo e dolore addominale, particolarmente nei pazienti con sindrome dell'intestino irritabile;
svolgere attività fisica regolare, specialmente aerobica, stimola la motilità intestinale attraverso meccanismi neuroendocrini e biomeccanici. Studi clinici hanno dimostrato che 30 minuti di esercizio moderato quotidiano possono migliorare significativamente la frequenza evacuativa e ridurre l'uso di lassativi nei pazienti con stipsi cronica;
rieducazione dell'alvo, che comprende l'abitudine a rispondere prontamente allo stimolo evacuativo e dedicare un tempo adeguato alla defecazione, preferibilmente al mattino dopo i pasti, sfrutta il riflesso gastro-colico per facilitare l'evacuazione.
Altri rimedi contro la stitichezza
Laddove i rimedi naturali contro la stitichezza non dovessero essere sufficienti o i disturbi dovessero essere persistenti, è possibile che il medico prescriva dei lassativi blandi e - in seguito ad esami di accertamento di primo e secondo livello è possibile che venga deciso di procedere con altri trattamenti.
Stitichezza, quando preoccuparsi
Sebbene la stipsi rappresenti frequentemente una condizione funzionale benigna, esistono scenari clinici in cui essa assume valore di segnale d'allarme, richiedendo tempestiva valutazione medica specialistica. Particolare attenzione meritano le modificazioni recenti e persistenti dell'alvo in soggetti di età superiore ai 50 anni, che possono costituire la manifestazione iniziale di neoplasie colorettali.
La stipsi di nuova insorgenza, specialmente se associata a sintomi sistemici come:
astenia
anemia o alterazioni degli indici infiammatori;
ematochezia, melena, dolore addominale severo o modificazioni del calibro fecale, particolarmente nella direzione di feci nastriformi che possono suggerire la presenza di lesioni stenosanti.
La stipsi acuta e severa, soprattutto se accompagnata da distensione addominale, vomito o assenza di canalizzazione ai gas, deve far sospettare una condizione occlusiva o sub-occlusiva che richiede valutazione in regime d'urgenza. Nei pazienti con stipsi cronica, l'emergere di sintomi neurologici come parestesie, debolezza agli arti inferiori, disfunzione vescicale o anale deve indurre alla ricerca di patologie neurologiche centrali o periferiche potenzialmente responsabili di stipsi neurogena.
Infine, la refrattarietà ai trattamenti convenzionali, con progressivo deterioramento della qualità di vita e necessità di dosi crescenti di lassativi, giustifica un approfondimento diagnostico completo, inclusa la valutazione della funzionalità del pavimento pelvico e del tempo di transito intestinale, per escludere forme secondarie di stipsi e indirizzare verso opzioni terapeutiche avanzate.
Prenota ora Visita Gastroenterologica
Cerca la prestazione medica di cui hai bisogno.
AutoreElty
Specializzati in tematiche di salute e benessere, ci impegniamo a fornirvi informazioni precise, aggiornate e facilmente accessibili per aiutarvi a vivere una vita più sana.
Chi siamo?
Elty è composto da un team di esperti in salute pubblica, nutrizionisti, medici e giornalisti scientifici. Uniamo le nostre diverse competenze per portarvi articoli che coprono un'ampia gamma di argomenti, dalla nutrizione alla salute mentale, dalla prevenzione delle malattie agli ultimi ritrovati della medicina.
La nostra missione
La nostra missione è chiarire il complesso mondo della salute e del benessere, rendendolo accessibile a tutti. Crediamo fermamente che un pubblico informato sia un pubblico più sano, e ci impegniamo a mantenervi aggiornati con contenuti affidabili e ben ricercati.
Articoli correlati
Scopri altri articoli per prenderti cura della tua salute...