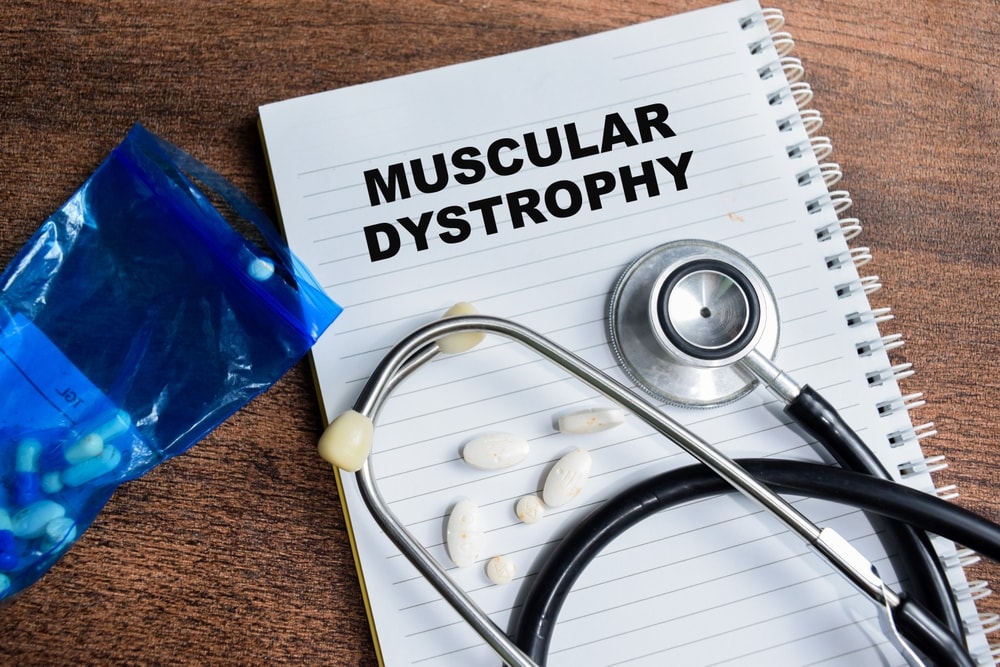Sclerosi multipla: come riconoscerla, diagnosticarla e affrontarla

Camminare su un sentiero familiare quando e, improvvisamente, una nebbia inaspettata avvolge il paesaggio: i contorni diventano sfocati, le sensazioni alterate, i movimenti incerti. Così si presenta spesso l'esordio della sclerosi multipla: un'invasione silenziosa che modifica la percezione del proprio corpo e del mondo circostante.
Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una patologia che colpisce quasi 2.000 nuovi casi ogni anno, prevalentemente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, trasformando vite ordinarie in percorsi di straordinaria resilienza.
Comprendere questa complessa condizione neurologica rappresenta il primo passo fondamentale per affrontarla con consapevolezza ed efficacia.
Sclerosi multipla cos'è
La sclerosi multipla (SM) è una patologia neurodegenerativa cronica, autoimmune e demielinizzante che colpisce il sistema nervoso centrale (SNC), composto da encefalo e midollo spinale.
Dal punto di vista patogenetico, si caratterizza per la presenza di processi infiammatori che determinano la progressiva distruzione della mielina, la guaina lipoproteica che riveste gli assoni neuronali, fondamentale per la corretta trasmissione degli impulsi nervosi.
Il danno alla mielina, definito demielinizzazione, causa la formazione di lesioni (placche o sclerosi) multiple e disseminate nel SNC, da cui deriva il nome della patologia. Queste lesioni interferiscono con la normale conduzione dell'impulso nervoso, determinando una vasta gamma di manifestazioni cliniche in relazione alla sede e all'estensione del danno.
La sclerosi multipla si presenta diverse forme cliniche che differiscono per decorso e prognosi:
recidivante-remittente: la forma più comune (85% dei casi all'esordio), caratterizzata da attacchi acuti (recidive) seguiti da periodi di remissione con recupero parziale o completo;
secondariamente progressiva: evoluzione della forma recidivante-remittente, con progressione continua della disabilità, con o senza recidive;
primariamente progressiva (SMPP): caratterizzata da progressione continua della disabilità fin dall'esordio, senza recidive distinte;
progressiva con recidive (SMPR): forma progressiva fin dall'esordio ma con chiare recidive acute, con o senza recupero completo.
La classificazione attuale tende a semplificare queste forme in due macrocategorie: SM a decorso recidivante e SM progressiva, riflettendo i diversi approcci terapeutici.
Sclerosi multipla sintomi
I sintomi della sclerosi multipla sono estremamente eterogenei e variabili, tanto da essere definita "la malattia dalle mille facce". I sintomi dipendono dalla localizzazione delle lesioni demielinizzanti nel SNC e possono manifestarsi in modo acuto durante le recidive o accumularsi progressivamente nel tempo.
I sintomi più comuni includono:
disturbi motori: debolezza muscolare, spasticità, difficoltà nella deambulazione, tremori, problemi di coordinazione;
disturbi sensitivi: parestesie (formicolii), disestesie, ipoestesia, dolore neuropatico;
disturbi visivi: neurite ottica, diplopia, nistagmo, offuscamento della vista;
disturbi dell'equilibrio: vertigini, instabilità posturale, atassia;
disturbi sfinterici: urgenza minzionale, incontinenza, ritenzione urinaria, stipsi;
disturbi cognitivi: difficoltà di concentrazione, problemi di memoria, rallentamento ideativo;
fatica: affaticamento sproporzionato rispetto all'attività svolta, peggiorato dal calore;
disturbi psichiatrici: depressione, ansia, labilità emotiva;
Il dolore alle dita delle mani rappresenta una manifestazione clinica non rara nella sclerosi multipla, sebbene meno frequentemente riportata rispetto ad altre sintomatologie.
Questi sintomi derivano dal coinvolgimento delle vie sensitive centrali e possono essere transitori durante le recidive o persistenti nelle forme progressive: è importante distinguerli da altre patologie quali la sindrome del tunnel carpale, l'artrite reumatoide o le neuropatie periferiche, che possono coesistere nei pazienti con SM.
Analogamente, il bruciore ai piedi è una manifestazione frequente del dolore neuropatico centrale nella sclerosi multipla che si caratterizza per:
sensazione urente persistente o intermittente, spesso descritta come "camminare su carboni ardenti";
esacerbazione notturna con conseguente disturbo del sonno;
associazione con allodinia (dolore provocato da stimoli normalmente non dolorosi);
distribuzione tipicamente simmetrica e distale.
Questo sintomo è causato dalla formazione di placche demielinizzanti lungo le vie spinotalamiche o talamocorticali deputate alla conduzione degli stimoli termici e dolorifici. Il bruciore ai piedi può rappresentare un sintomo d'esordio in circa il 10-15% dei pazienti o manifestarsi nel corso della malattia, contribuendo significativamente alla riduzione della qualità della vita.
Il bruciore cutaneo diffuso rappresenta una variante del dolore neuropatico centrale e si manifesta come:
Tutti i disturbi sensitivi sono correlati alla presenza di lesioni demielinizzanti a livello del cordone posteriore del midollo spinale o delle vie talamocorticali. La comprensione di questi sintomi risulta fondamentale per un corretto inquadramento diagnostico e per l'impostazione di adeguate strategie terapeutiche volte al controllo del dolore neuropatico.
Sclerosi multipla cause
L'eziologia della sclerosi multipla è multifattoriale e non completamente chiarita. Il modello patogenetico attualmente più accreditato identifica la SM come una patologia autoimmune che si sviluppa in individui geneticamente predisposti, in seguito all'esposizione a fattori ambientali trigger.
I principali fattori eziologici includono:
fattori genetici: la SM non è una malattia strettamente ereditaria, ma esiste una predisposizione genetica poligenica. I dati epidemiologici evidenziano un rischio relativo aumentato nei familiari di primo grado (15-35 volte superiore rispetto alla popolazione generale). Studi di associazione genome-wide hanno identificato oltre 200 varianti geniche associate alla SM, principalmente correlate alla regolazione del sistema immunitario;
infezioni virali: Il virus di Epstein-Barr (EBV) rappresenta il fattore di rischio infettivo più solidamente associato alla SM. La sieroprevalenza per EBV nei pazienti con SM supera il 99%, rispetto all'89-94% della popolazione generale. Recenti studi hanno evidenziato come l'infezione da EBV preceda lo sviluppo della SM, suggerendo un ruolo patogenetico attraverso meccanismi di mimetismo molecolare o attivazione di risposte immunitarie aberranti;
deficit di vitamina D: esiste una correlazione inversa tra livelli di vitamina D e rischio di SM, supportata dall'osservazione della distribuzione geografica della patologia, più prevalente alle alte latitudini. La vitamina D esercita effetti immunomodulatori che potrebbero proteggere dallo sviluppo della malattia;
fumo di sigaretta: il tabagismo è associato non solo a un aumentato rischio di sviluppare la SM, ma anche a una peggiore prognosi, con maggiore tendenza alla progressione e minore risposta alle terapie;
obesità: l'obesità in età pediatrica e adolescenziale è correlata a un aumentato rischio di sviluppare la SM, probabilmente attraverso meccanismi infiammatori sistemici;
microbiota intestinale: recenti evidenze suggeriscono un ruolo della disbiosi intestinale nella patogenesi della SM, attraverso alterazioni dell'asse intestino-cervello e modulazione delle risposte immunitarie.
Il modello patogenetico attuale prevede una fase iniziale di attivazione periferica di linfociti T autoreattivi contro antigeni mielinici, seguita dalla migrazione di queste cellule attraverso la barriera emato-encefalica nel SNC, dove innescano una cascata infiammatoria che porta al danno della mielina e, nelle fasi avanzate, alla degenerazione assonale.
La sclerosi multipla è ereditaria?
La sclerosi multipla non è considerata una malattia strettamente ereditaria secondo i criteri mendeliani classici, ma presenta una significativa componente di suscettibilità genetica.
Come si diagnostica la sclerosi multipla
La diagnosi di sclerosi multipla si basa su un approccio integrato che comprende l'anamnesi, l'esame neurologico e indagini strumentali specifiche. I criteri diagnostici attualmente utilizzati sono i Criteri di McDonald, revisionati nel 2017, che si fondano sul concetto di "disseminazione spaziale e temporale" delle lesioni demielinizzanti, ovvero la presenza di lesioni in diverse aree del SNC che si sviluppano in tempi diversi.
Il percorso diagnostico inizia tipicamente con una visita neurologica approfondita, seguita da indagini strumentali di conferma e dall'esclusione di patologie alternative che possono mimare la SM (diagnosi differenziale).
La visita neurologica rappresenta un momento cruciale nel percorso diagnostico del paziente con sospetta sclerosi multipla. Il neurologo raccoglie innanzitutto un'anamnesi dettagliata, focalizzandosi su:
caratteristiche ed evoluzione temporale dei sintomi
eventi neurologici pregressi potenzialmente riconducibili a recidive non riconosciute
familiarità per SM o altre patologie autoimmuni
fattori di rischio ambientali (geografici, infettivi, abitudini di vita)
L'esame neurologico obiettivo è condotto in modo sistematico e comprende la valutazione di:
funzioni corticali superiori: orientamento, memoria, linguaggio, funzioni esecutive
nervi cranici: acuità visiva, campi visivi, motilità oculare, riflessi pupillari, funzioni sensitive e motorie facciali
sistema motorio: forza muscolare, tono, riflessi osteo-tendinei, riflessi patologici (segno di Babinski)
sistema sensitivo: sensibilità tattile, dolorifica, termica, vibratoria e propriocettiva
coordinazione: prove indice-naso, tallone-ginocchio, diadococinesi
equilibrio e deambulazione: prova di Romberg, tandem gait, marcia spontanea
Per quantificare il grado di disabilità, viene comunemente utilizzata la scala EDSS (Expanded Disability Status Scale), che valuta otto sistemi funzionali (piramidale, cerebellare, tronco encefalico, sensitivo, intestino e vescica, visivo, cerebrale o mentale, altri) e assegna un punteggio complessivo da 0 (esame neurologico normale) a 10 (morte dovuta a SM).
La visita neurologica può evidenziare segni caratteristici, come il nistagmo, l'oftalmoplegia internucleare, l'iperriflessia con segno di Babinski positivo, deficit di forza e sensibilità con distribuzione compatibile con lesioni del SNC. Tuttavia, nei casi precoci o in fase di remissione, l'esame obiettivo può risultare nella norma, rendendo necessario il ricorso alle indagini strumentali.
Gli esami
Il processo diagnostico della sclerosi multipla si avvale di diverse indagini strumentali e di laboratorio, ciascuna con specifiche indicazioni e significato clinico.
La risonanza magnetica è l'indagine strumentale più importante, con elevata sensibilità nel rilevare le lesioni demielinizzanti: l’esame consente di valutare sia la disseminazione spaziale (presenza di lesioni in aree tipiche: periventricolare, juxtacorticale, infratentoriale, spinale) che temporale (comparsa di nuove lesioni nel tempo o presenza contemporanea di lesioni enhancing e non enhancing). L'esame dovrebbe includere sia l'encefalo che il midollo spinale, in particolare nei casi con sintomatologia prevalentemente midollare.
In alcuni casi il neurologo può prescrivere anche l’esame del liquido cerebrospinale (LCS) e gli esami ematochimici, inclusi VES e PCR:
La velocità di eritrosedimentazione (VES) e la proteina C-reattiva (PCR) sono marcatori aspecifici di infiammazione sistemica che rivestono un ruolo particolare nel percorso diagnostico della SM.
Paradossalmente, nella sclerosi multipla, nonostante il processo infiammatorio in corso nel SNC, questi parametri risultano tipicamente nella norma. Questo dato ha un notevole valore diagnostico differenziale:
VES e PCR normali in presenza di sintomatologia neurologica suggestiva orientano verso la SM o altre patologie neurologiche non sistemiche
VES e PCR elevate suggeriscono patologie alternative come vasculiti sistemiche, malattie reumatologiche, infezioni o neoplasie
L'interpretazione integrata di questi esami, unitamente al quadro clinico e neuroradiologico, consente di formulare una diagnosi accurata secondo i criteri di McDonald 2017, che permettono la diagnosi di SM anche dopo il primo episodio clinico (sindrome clinicamente isolata, CIS) in presenza di specifici criteri di disseminazione spaziale e temporale.
È fondamentale sottolineare l'importanza di un approccio diagnostico accurato e tempestivo, poiché l'inizio precoce delle terapie modificanti il decorso è associato a migliore prognosi a lungo termine.
FAQ
Sclerosi multipla e aspettativa di vita
L'aspettativa di vita nei pazienti con sclerosi multipla è significativamente migliorata negli ultimi decenni. Attualmente, si stima una riduzione dell'aspettativa di vita di circa 5-10 anni rispetto alla popolazione generale. Questo miglioramento è attribuibile all'introduzione delle terapie modificanti il decorso, alla migliore gestione delle complicanze e all'approccio multidisciplinare. I fattori prognostici sfavorevoli comprendono l'esordio tardivo, le forme progressive all'esordio, il coinvolgimento multisistemico precoce e la scarsa risposta ai trattamenti. La causa di morte è correlata a complicanze della malattia nel 50-60% dei casi.
Sclerosi multipla e sla: c’è una differenza?
Sclerosi multipla (SM) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) sono patologie neurologiche completamente distinte. La SM è una malattia autoimmune demielinizzante che colpisce il sistema nervoso centrale con danno alla guaina mielinica, manifestandosi con sintomi multifocali e decorso prevalentemente recidivante-remittente nei giovani adulti. La SLA è una malattia neurodegenerativa che colpisce selettivamente i motoneuroni, causando progressiva atrofia muscolare e paralisi, con esordio generalmente dopo i 50 anni e decorso invariabilmente progressivo. Le due patologie differiscono per eziopatogenesi, decorso clinico, diagnosi, terapie e prognosi.
La sclerosi multipla dopo i 50 anni si può manifestare?
L'esordio della sclerosi multipla dopo i 50 anni (late-onset MS) rappresenta circa il 4-9% di tutti i casi diagnosticati. Le manifestazioni cliniche nell'età avanzata presentano alcune peculiarità: predominanza delle forme progressive fin dall'esordio (50-60%), sintomatologia prevalentemente motoria e cerebellare, minore incidenza della neurite ottica rispetto alle forme giovanili. La diagnosi risulta più complessa per la frequente coesistenza di comorbidità vascolari e degenerative. La risposta alle terapie immunomodulanti è generalmente inferiore e la progressione della disabilità più rapida, richiedendo un approccio terapeutico multidisciplinare con particolare attenzione alla gestione dei sintomi.
Prenota ora una Visita Neurologica
Cerca la prestazione medica di cui hai bisogno.
AutoreElty
Specializzati in tematiche di salute e benessere, ci impegniamo a fornirvi informazioni precise, aggiornate e facilmente accessibili per aiutarvi a vivere una vita più sana.
Chi siamo?
Elty è composto da un team di esperti in salute pubblica, nutrizionisti, medici e giornalisti scientifici. Uniamo le nostre diverse competenze per portarvi articoli che coprono un'ampia gamma di argomenti, dalla nutrizione alla salute mentale, dalla prevenzione delle malattie agli ultimi ritrovati della medicina.
La nostra missione
La nostra missione è chiarire il complesso mondo della salute e del benessere, rendendolo accessibile a tutti. Crediamo fermamente che un pubblico informato sia un pubblico più sano, e ci impegniamo a mantenervi aggiornati con contenuti affidabili e ben ricercati.
Articoli correlati
Scopri altri articoli per prenderti cura della tua salute...